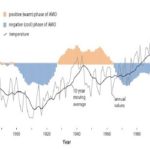di Nicolò Passeri

La storia, a sua volta, è sempre contemporanea, nel senso che essa è legata al presente, nella persona e nell’ambiente dello storico, che muove sempre nell’opera sua da propri interessi attuali. Benedetto Croce
Introduzione
Il fenomeno del cambiamento climatico costituisce uno dei temi di maggiore rilievo su scala planetaria, coinvolgendo gli Stati nazionali e interessi comuni che convergono verso strategie di mitigazione e adattamento. Tali strategie mirano a consentire il mantenimento delle consuete abitudini umane e, al contempo, a tutelare le dinamiche climatiche mondiali e la biodiversità esistente.
Al di là del negazionismo, esiste una percezione condivisa della relazione che esiste tra le dinamiche climatiche e le prospettive di vita.
Questo estratto, che approfondisce la lettura del testo di Carpenter “Clima e storia”, vuole mettere in risalto come le dinamiche climatiche possono avere influito sul destino dell’umanità, e come poi l’uomo abbia saputo adattare i propri comportamenti, ovvero mitigare gli effetti del cambiamento, scrivendo l’evoluzione storica.
La presente lettura, senza alcuna pretesa di fornire un’analisi storiografica in senso stretto, si propone come una riflessione critica a posteriori su alcune dinamiche che potrebbero essere spiegate proprio alla luce del cambiamento climatico. È possibile che l’attuale aumento di consapevolezza coincida con un periodo storico che si ripete a livello globale, già sperimentato da civiltà del passato, ma che oggi, con ogni probabilità, abbiamo contribuito ad accelerare. Tale considerazione invita a comprendere come, di fronte a un futuro potenzialmente problematico, occorra individuare soluzioni adeguate, magari mutando comportamenti consolidati e traendo insegnamento da eventi di un passato ormai remoto.
Le variazioni climatiche e la loro incidenza sulle civiltà umane
Le forti alterazioni del clima non riguardano soltanto le epoche geologiche più remote, ma costituiscono parte della reale esperienza umana del passato. Nella storia della civiltà si possono individuare almeno due regressioni culturali che riconducono direttamente a mutamenti climatici. Quando la coltre di ghiaccio si estendeva sull’Europa settentrionale fino a raggiungere, a sud, la latitudine di Londra e Parigi, i ghiacciai nelle valli della Svizzera – più estesi di quanto non siano oggi – formavano una barriera formidabile nella parte meridionale del continente (tra circa 20.000 e 18.000 anni fa). Tra queste due fronti invalicabili si trovava un corridoio, delimitato dal ghiaccio a nord e dalle montagne coperte di neve a sud, che conduceva a ovest dall’Asia interna fino alla costa atlantica.
Alla fine di questo corridoio, corrispondente all’attuale territorio francese, le correnti provenienti dall’Atlantico non gelato portavano umidità e mitigavano in parte i rigori dell’atmosfera. Una razza di cacciatori viveva in questa zona, circondata da branchi di animali selvatici – renne, bisonti, mammut – che fornivano cibo e risorse. Le pitture rupestri nelle caverne rimangono testimonianza del passaggio di queste popolazioni. Quando i ghiacci iniziarono a ritirarsi, quei cacciatori videro scomparire i branchi da cui traevano sostentamento. L’aumento di calore e di umidità modificava i terreni su cui gli animali pascolavano, mentre gli arbusti lasciavano il posto a foreste e acquitrini. Cacciatori e animali tentarono allora di mantenere le loro abitudini, e si spinsero lungo il “grande corridoio europeo” fino alla Russia e, in seguito, in Siberia, dove si perdono le loro tracce. Questa migrazione coincise con il declino dell’abilità artistica, con l’involuzione dell’artigianato e con un generale impoverimento della vita. Fu, dunque, la prima grande recessione culturale connessa a un mutamento del clima.

La formazione del Sahara e altre trasformazioni regionali
La seconda profonda trasformazione climatica fu la nascita del vasto deserto nordafricano: il Sahara, esteso quanto l’intera Europa continentale. Alla fine dell’ultima epoca glaciale, lo scioglimento dei ghiacci europei comportò infatti la trasformazione di ampie zone di rigogliosi pascoli nordafricani in terre desolate, aride e appena abitabili. Secondo l’analisi di Carpenter (1969), alcuni paralleli si riscontrano anche in altre regioni, come nel cuore della Turchia, oggi soprannominata la “regione delle mille e una chiese”.
Malgrado non vi siano mai state effettivamente mille chiese, se ne costruirono moltissime tra il V e il VI secolo, a testimonianza di un’alta densità demografica. Durante il VII secolo e dopo, tuttavia, non ne vennero più costruite e molte di quelle esistenti caddero in rovina. Non risulta che la dominazione araba sia stata distruttiva, poiché la popolazione in Siria accettò spontaneamente le condizioni dei capi arabi. Vi fu quindi un altro fattore che provocò la desolazione di queste chiese di pietra: la diminuzione delle sorgenti, conseguenza del venir meno delle piogge annuali. Senza l’acqua, né esseri umani né animali, né la vegetazione stessa, potevano sopravvivere.
Contrasti climatici tra Mediterraneo ed Europa del Nord
Nello stesso periodo in cui si verificarono recessioni in Grecia e in Siria, l’Europa del Nord conobbe, al contrario, una fase di prosperità. Se il periodo tra VII e IX secolo è definito “secoli bui”, esso vide tuttavia la civiltà in ascesa in Francia, Germania e Britannia. Si ritiene che in Inghilterra il clima fosse eccezionalmente favorevole, dal momento che l’uva riusciva a maturare e si produceva vino, cosa impensabile in epoca romana. Anche i monasteri in Irlanda raggiunsero un livello di prosperità e cultura senza precedenti, mentre in Scandinavia, nel IX secolo, la popolazione crebbe così tanto da spingere all’espansione coloniale. Nei decenni successivi, i norvegesi emigrarono in Islanda e in Groenlandia, che all’epoca era sufficientemente verde da giustificare la denominazione di “Terra verde”. Solo alla fine del XIII secolo il ghiaccio polare avanzò lungo la costa groenlandese, peggiorando il clima al punto che alla fine del XIV secolo la popolazione di origine europea dovette abbandonare il paese, cedendo il posto alle popolazioni eschimesi.
Le analisi del polline rinvenuto nelle torbiere dell’Europa centro-settentrionale hanno permesso di ricostruire, attraverso le tracce stratificate della vegetazione arborea, l’evoluzione delle variazioni di temperatura e precipitazioni. Persino il grado di praticabilità dei passi alpini è stato impiegato come indicatore di mutamenti climatici regionali.
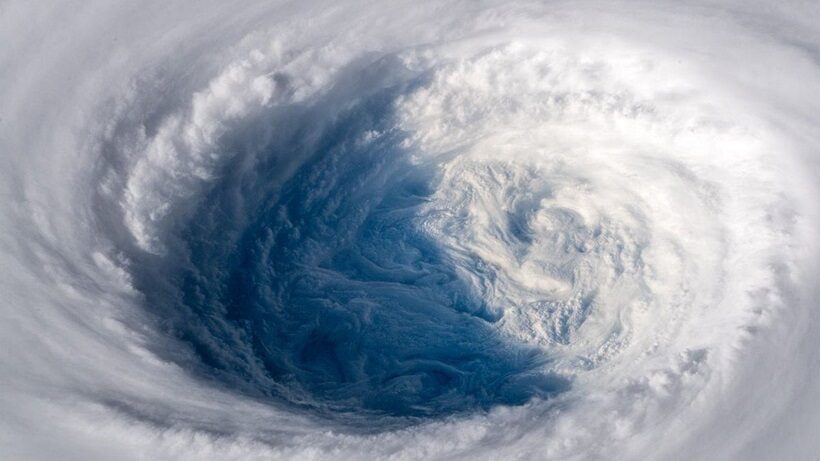
Il declino culturale miceneo e la questione dorica
Il declino della civiltà micenea costituisce un caso particolarmente significativo di collasso culturale. Alcune teorie lo attribuiscono a una presunta “senilità naturale”, secondo una visione biologico-storica mutuata da Spengler, che immaginerebbe un’inevitabile “vecchiaia” delle civiltà, impossibile da contrastare. Un’altra ipotesi suggestiva individua come causa l’invasione dei Dori provenienti da nord, i quali avrebbero invaso e sottomesso i territori di Argo, Aulide e del Peloponneso, costringendo le popolazioni locali alla fuga.
Tuttavia, per la Laconia e la Messenia, che erano distretti floridi, gli scavi e i rilievi archeologici mostrano un abbandono quasi totale degli abitanti tra il 1200 e il 1150 a.C., senza che vi siano tracce di insediamenti successivi o di presenze straniere. Non emergono, inoltre, segni di distruzione attribuibili a un’invasione: è come se gli aggressori, ammesso che esistessero, si fossero dileguati nell’aria senza stabilirsi in alcuna località.
Da ciò si deduce che i Dori non hanno avuto un ruolo nel crollo della civiltà micenea, essendo penetrati nel Peloponneso solo molto tempo dopo il declino. La disintegrazione politica e culturale micenea non fu, dunque, dovuta a violenze esterne, bensì a condizioni locali che costrinsero la popolazione ad abbandonare gran parte dei centri minori e a saccheggiare i palazzi della casta dominante, lasciando il territorio quasi deserto per due secoli. Ciò non significa negare l’importanza storica dell’occupazione dorica o del “ritorno degli Eraclidi” come nuovi governanti di tribù di lingua dorica, ma si colloca tale evento in un periodo successivo alla fine dell’era micenea.
Carestie, pestilenze e spostamenti di popolazioni
Secondo Erodoto, dopo la guerra di Troia, Creta fu devastata da carestia e pestilenza a tal punto da rimanere praticamente deserta, finché non venne ripopolata da nuove genti. Parallelamente, intorno al 1200 a.C., anche gli Ittiti subirono gli effetti di una grave carestia, mentre un’altra colpì la Lidia tanto duramente da costringere metà della popolazione a emigrare verso l’Etruria italica.
Questi fenomeni sembrano suggerire che la civiltà micenea sia stata travolta da una crisi climatica – in particolare da lunghi periodi di siccità, responsabili della carestia. L’Aliseo, vento che domina il Mediterraneo orientale, risulta determinante per le estati asciutte dell’Egeo, poiché in quel periodo dell’anno blocca i venti atlantici carichi di umidità diretti verso l’Europa centrale e impedisce loro di penetrare fino alla parte meridionale dei Balcani.
Ipotesi sullo spostamento delle fasce climatiche
Questa crisi climatica si sarebbe potuta verificare con uno spostamento verso nord del fronte polare contro cui si infrange l’Aliseo: aumenti di temperatura a livello planetario avrebbero potuto indebolire il gradiente termico tra equatore e polo, favorendo una maggiore estensione dell’Aliseo verso nord. Anche se, con la diminuzione del gradiente termico, l’intensità dell’Aliseo si sarebbe potuta attenuare, esso avrebbe comunque portato siccità sull’Egeo durante l’estate. Nella tarda primavera e in autunno, spostandosi ancora più a nord, avrebbe allontanato le piogge cicloniche dal consueto percorso mediterraneo.
Conseguenza di ciò sarebbe potuto essere l’aumento a circa otto mesi di siccità continua, rispetto ai quattro o cinque attuali, decretando un disastro per la maggior parte delle specie viventi in tempi relativamente brevi. Sarebbero comunque rimaste però aree più ristrette in cui l’orografia avrebbe favorito almeno alcune precipitazioni. Le coste occidentali della Grecia, dalla Messenia settentrionale all’Epiro, avrebbero potuto ricevere piogge abbondanti dai venti umidi del Mar Ionio, mentre la Messenia meridionale, la Laconia e l’Argolide sarebbero rimaste quasi del tutto prive di precipitazioni. Attraversando l’ampio Egeo, i venti occidentali avrebbero riacquistato invece umidità, scaricandola sulle isole montuose di Chio, Icaria e Samo, vicine alla costa dell’Asia Minore.
Conseguenze sul panorama greco e fine dell’era micenea
Tale quadro di disordine climatico, fondato su persistenti siccità e carestie, spinse i Micenei a lasciare la maggior parte della Grecia continentale, portando al crollo della prosperità che avevano conosciuto. Queste condizioni drammatiche costrinsero infatti gli abitanti a migrare, decretando la fine della fiorente epoca micenea.
È possibile, inoltre, trarre ulteriori indicazioni di un marcato mutamento climatico dall’osservazione di alcuni aspetti culturali della Grecia classica: l’abbigliamento passò dagli abiti leggeri di tipo minoico e miceneo a vesti più pesanti, mentre i tetti piatti vennero sostituiti da coperture a spiovente, segnali di maggiori precipitazioni. Vi è dunque la concreta ipotesi che il clima sia cambiato sensibilmente proprio in corrispondenza dell’inizio della civiltà greca classica.
Conclusioni
Le dinamiche illustrate confermano come i mutamenti climatici abbiano inciso profondamente sulle vicende umane, determinando migrazioni di massa, crolli culturali e radicali ristrutturazioni sociali. Alla luce di quanto emerso nel paragrafo introduttivo, in cui si sottolinea la rilevanza planetaria di questo tema e la necessità di strategie di mitigazione e adattamento, appare evidente che i fenomeni di instabilità climatica abbiano già condizionato in passato il destino di intere civiltà.
L’analisi di Carpenter (Clima e storia, Torino, Einaudi, 1969, Nuovo Politecnico, 32) mostra come fattori climatici, ambientali e demografici possano essere determinanti per l’ascesa e il declino delle società. Vicende come quelle dei Micenei, delle regioni nordafricane o dell’Europa settentrionale, se confrontate con dati archeologici e paleoclimatici, rivelano l’importanza cruciale del clima nella storia, un argomento ancora oggi attuale e, anzi, reso più urgente dall’influsso umano.
La riflessione su questi eventi, letti ora anche come possibili precursori delle sfide che il mondo contemporaneo si trova ad affrontare, invita a considerare come il nostro accresciuto livello di consapevolezza coincida forse con l’ennesimo ripresentarsi di un ciclo storico. Rispetto al passato, tuttavia, l’azione antropica potrebbe aver accelerato tali processi, rendendo più urgente l’individuazione di soluzioni che implichino il cambiamento di comportamenti consolidati e l’apprendimento dalle esperienze di civiltà ormai lontane. Solo così sarà possibile fronteggiare uno scenario climatico problematico e delineare un futuro più sostenibile.
La vita, come una cupola di vetro variopinto, macchia il fulgore bianco dell’eternità.
Adonais, Percy Bysshe Shelley
Nicolò Passeri. Agronomo, libero professionista, Dottore di ricerca in “Economia e Territorio”. Si occupa di consulenze tecnico-legali nei contenziosi, supporta le imprese nell’iter delle certificazioni agroalimentari e svolge analisi tecnico economiche dei processi produttivi. Sugli stessi temi svolge docenze rivolte a operatori e tecnici del comparto agroalimentare. Collabora con l’Università degli Studi della Tuscia. Per info: Google “Nicolò Passeri Agronomo”.