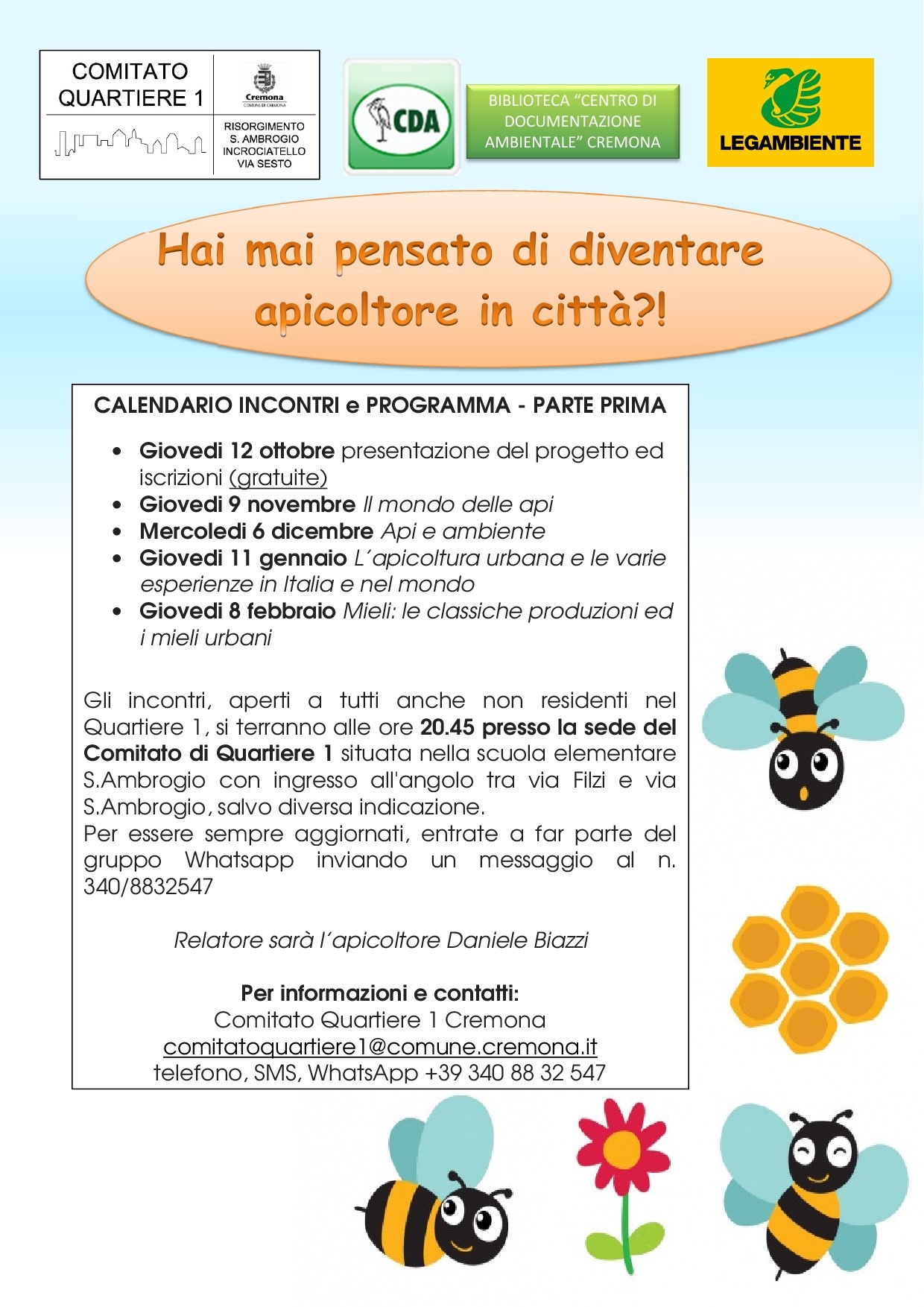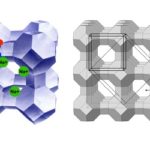di Ezio Casali
La possibilità di indagare lo stato dell’ambiente rappresenta uno dei fondamenti di tutti gli studi che hanno come obiettivo quello di valutare gli eventuali livelli di inquinamento di un ecosistema più o meno grande, e questa possibilità è legata sia all’utilizzo di apparecchiature di laboratorio sia di esseri viventi che vengono utilizzati come veri e propri strumenti di misura della salute del territorio in cui vivono.
Negli ultimi decenni l’approccio a questa tipologia di tematiche si è evoluto orientandosi verso un metodo più multidisciplinare e cercando di valutare le molteplici interazioni tra tutti i componenti di un ecosistema attraverso lo studio dei rapporti intra ed interspecifici.
Su queste basi nel 1977, René Truhaut (1909 – 1994, professore di Tossicologia alla Facoltà di Medicina dell’Università di Parigi), definì il termine di ecotossicologia come “la branca della tossicologia che si occupa dello studio degli effetti tossici, causati da inquinanti naturali o sintetici, sui costituenti degli ecosistemi, animali (inclusi gli umani), vegetali e microbi, in un contesto integrale”. Questa metodologia di indagine si differenzia dalla tossicologia ambientale in quanto quest’ultima analizza gli effetti non a livello globale, bensì focalizzandosi sugli effetti che una sostanza provoca a livello individuale o addirittura inferiore (un apparato, un organo, un tessuto, ecc,).
Uno dei punti di maggior qualificazione di questa disciplina è l’utilizzo dei cosiddetti bioindicatori (o indicatori biologici o specie indicatrice), definiti come “una specie animale, pianta o fungo particolarmente sensibile a cambiamenti apportati da fattori inquinanti all’ecosistema” ed utilizzata nel biomonitoraggio, cioè nell’insieme delle metodologie che utilizzano organismi viventi per trarre informazioni sullo stato dell’ambiente.
Più precisamente i bioindicatori, vere e proprie sentinelle ambientali, vengono classificati in bioindicatori propriamente detti ed in bioaccumulatori: i primi risultano particolarmente sensibili al principio attivo studiato, mentre i bioaccumulatori, vista la loro resistenza alla molecola oggetto di indagine, sono in grado, appunto, di accumularla nel loro organismo.
Si parla quindi di bioindicatori quando le variazioni del loro stato naturale in presenza di sostanze inquinanti sono apprezzabili e rilevabili e di bioaccumulatori invece quando sono in grado di sopravvivere alla presenza di una determinata sostanza tossica, accumulandola e permettendone una qualificazione e una quantificazione.
Tra le specie utilizzate nel biomonitoraggio rilievo particolare lo rivestono gli insetti e gli aracnidi (api, formiche, ragni, ecc.), ma anche molluschi (mitili, ecc.), licheni e piante superiori (gladiolo, vite, tabacco nonché in casi particolari intere foreste, ecc).
Uno dei primi casi documentati di biomonitoraggio ambientale con gli insetti, risale al 1935 in Cecoslovacchia, dove le api vennero utilizzate per rilevare le ripercussioni negative degli inquinanti industriali sulle bottinatrici (le api che vanno a raccogliere il nettare) nei territori densamente popolati e industrializzati.

Ape Apis mellifera bottinatrice (Fonte: Wikimedia Commons)
Proprio le api, viste la loro organizzazione sociale, sono tra le specie ancora oggi più utilizzate sia come bioindicatori (in particolar modo nello studio sugli effetti tossici dei prodotti fitosanitari, che portano ad elevata mortalità) che come bioaccumulatori (quando invece si monitorano inquinamenti per esempio da metalli pesanti o da radionuclidi che vengono accumulati nell’organismo per poi essere qualificati e quantificati con relativa facilità).
Le caratteristiche che fanno delle api degli ottimi insetti utilizzabili nel settore dell’ecotossicologia sono molteplici:
- sono facili ed economiche da allevare, per cui la loro disponibilità e reperibilità sono massime;
- adattandosi a situazioni ambientali e climatiche molto diverse tra loro, sono pressochè ubiquitarie e quindi utilizzabili in molteplici contesti;
- i loro fabbisogni alimentari sono abbastanza semplice ed in alcuni casi si potrebbe anche ricorrere all’alimentazione artificiale (anche se in questo caso, esplorando meno l’ambiente, potrebbero perdere un po’ di valore come indicatori);
- la presenza di peli sul corpo permette loro di raccogliere e trattenere eventuali sostanze, disperse nell’atmosfera o presenti sulle piante dove vanno a bottinare, rendendoli disponibili ai ricercatori;
- si riproducono molto velocemente, permettendo così di analizzare colonie in continua evoluzione, mutamento e ricambio
- esplorano aree molto vaste per bottinare con un un raggio d’azione molto ampio che va da 1 a 2 chilometri fino ad arrivare a 13 chilometri (basti pensare che un raggio di bottinamento di 2 Km corrisponde a 1.256 ettari di territorio esplorato);
- la loro capacità di esplorare, grazie al fatto che le 20.000 – 25.000 bottinatrici di un alveare sono in grado di compiere anche 6 voli giornalieri visitando più fiori per volo, massivamente tutti i componenti di un ambiente (acqua, aria, piante, ecc,);
- forniscono matrici di controllo diverse (miele, melata, propoli, le api stesse) con la conseguente possibilità di controllare molecole anche molto diverse tra loro.
Relazione tenuta il 6 dicembre 2017 presso il Quartiere 1 del Comune di Cremona nell’ambito del progetto “Cremona Urban Bees”.
La bibliografia è disponibile presso l’autore.

Ezio Casali, iscritto all’Albo Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cremona, insegna presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Stanga” di Cremona. Si occupa di autocontrollo, soprattutto negli agriturismi, e di agricoltura multifunzionale. Curriculum vitae >>>