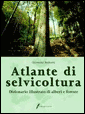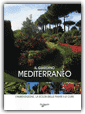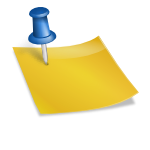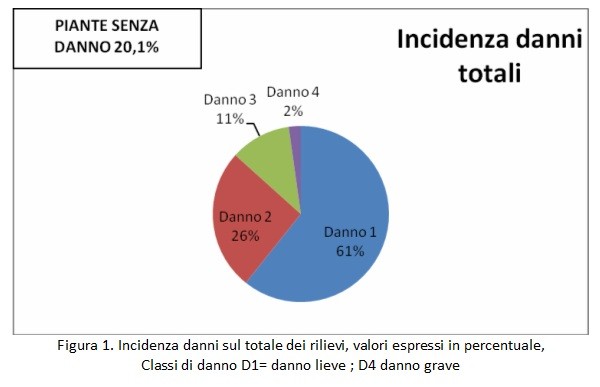di Marco Giuseppi
Il sistema insediativo italiano è stato caratterizzato da una relativa stasi fino al secondo dopoguerra, fatta eccezione per alcuni cambiamenti relativi ai primi insediamenti industriali urbani e vallivi di fine ‘800. La situazione delle campagne e i paesaggi che ne erano espressione venivano caratterizzati da una certa stabilità e da un rapporto gerarchico della campagna verso la città: la campagna produceva quello che la città consumava.
L’Italia rispetto ad altre zone europee ha conosciuto il fenomeno di abbandono delle campagne in tempi relativamente recenti, dal secondo dopoguerra si è instaurata nel paese un’intensa fase di cambiamenti e di crescita economica, che ha provocato un forte processo di inurbamento e di espansione dei nuclei abitati con relativo cambio delle forme di uso del suolo e conseguente abbandono di terreni agricoli marginali. Si stima che dagli anni Settanta la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) sia diminuita del 28%, passando dai 18 mln di ettari degli anni ’70 agli attuali 13 mln, con quindi una perdita netta di ben 5 mln di ettari; in questi terreni si sono spesso innescati fenomeni di successione secondaria, determinando anche notevoli modificazioni del paesaggio, con un graduale ritorno del bosco.

Figura 1: Esempio di cambiamento di uso del suolo, con ingente perdita di terreni coltivati nella città di Firenze. Foto a sinistra 2013, foto a destra 1954.
La campagna ha perso il rapporto di tipo funzionale che storicamente la legava alla città, ed il progressivo affrancamento che ha interessato le aree urbane, dovuto alle nuove tecniche di conservazione e produzione degli alimenti, ha fatto sì che i territori rurali prossimi alla città entrassero con un rapporto di subordinazione nelle dinamiche di sviluppo e pianificazione della città e strettamente legati alle sue evoluzioni. Inizialmente quindi la priorità è stata quella di contenere l’avanzamento dell’agglomerato urbano a danno dei territori agricoli che si è tradotta essenzialmente in modelli di “protezione” iscrivibili in tre categorie:
- La “cintura verde” che si propone di creare una cintura oltre la quale impedire l’avanzamento dell’agglomerato urbano, impedendo anche fenomeni di saldatura tra diversi agglomerati.
- Il “cuneo verde” porzioni agricole che dall’esterno penetrano dentro il tessuto urbano.
- Il “cuore verde” che conserva le aree agricole all’interno delle aree urbanizzate.
Negli anni successivi al boom economico, la congestione urbana e il crescente inquinamento, si sono tradotti molto presto in un disagio forte della popolazione, che ha avuto come effetto quello di rallentare la crescita demografica delle città fino ad arrivare ai fenomeni di cosiddetta rururbanizzazione, cioè la migrazione dei cittadini verso le campagne periurbane e nei paesi di cintura. La rururbanizzazione porta con sé due fenomeni distinti:
- Aggressione del territorio attraverso la costruzione a macchia di leopardo di nuovi nuclei.
- Rivalutazione del concetto di rurale con la creazione di una nuova categoria di spazio (il periurbano) che non rientra nelle categorie né di urbano né di rurale.
È in questi territori che si sono istaurati negli ultimi anni interessanti rapporti tra i “cittadini neo – rurali” e i vecchi abitanti delle campagne che hanno creato nuove comunità e nuove concezioni di ruralità nelle quali si inseriscono gli sviluppi dell’agricoltura periurbana, se infatti i cittadini neo- rurali hanno un approccio maggiormente di tipo paesaggistico – ambientale e vedono l’attività agricola sostanzialmente dal punto di vista ricreativo, i vecchi abitanti delle campagne sono spesso rimasti ad una concezione produttiva dell’agricoltura.
È a causa di questi differenti approcci che a partire dagli anni novanta del ‘900 anche in Italia è cresciuta l’importanza per le aree agricole periurbane come strumenti di progettazione operativa, su modello delle green belt (cinture verdi) inglesi e di altri esempi europei, nel tentativo di frenare il fenomeno della frantumazione dello spazio agricolo periurbano innescatosi con il boom economico del dopoguerra.

Figura 2: Sistema di aree verdi che circondano la città di Londra per limitare la proliferazione di nuove costruzioni. Fonte: www.standard.co.uk
Di conseguenza sono anche aumentate le aspettative verso questi spazi verdi, che si traducono spesso in progetti di pianificazione sempre più complessi che hanno lo scopo di preservare le funzionalità degli spazi agricoli dove la funzione produttiva si unisce e a volte soccombe alla funzione ambientale e paesaggistica.
Il riconoscimento del ruolo multifunzionale dell’agricoltura gioca infatti un ruolo fondamentale nella sua tutela e nel suo sviluppo, sono necessari progetti specifici che mirino ad un equilibrio tra pianificazione territoriale e agricoltura, riconoscendo la specificità di ogni singolo fattore specialmente quando le ipotesi progettuali si inseriscono in contesti paesaggistici delicati e con una marcata influenza delle azioni dell’uomo, dove la millenaria interazione tra processi naturali, culturali e attività umane ha plasmato in modo deciso il paesaggio, come nel caso di buona parte del paesaggio italiano. Il territorio italiano infatti ha subito profondissime manipolazioni, tanto che risulta oggi difficile considerarlo un paesaggio naturale: si tratta a tutti gli effetti di un “paesaggio culturale” come definito dall’UNESCO nel 1972, inteso come un paesaggio che: abbraccia oggi una pluralità di manifestazioni della interazione tra l’uomo e il suo ambiente naturale e nel quale anche porzioni apparentemente incontaminate sono in realtà legate all’azione dell’uomo.
Anche i luoghi verdi infatti hanno avuto nel corso dei secoli funzioni e caratteristiche diverse che rispondevano alle diverse esigenze sociali e culturali; si è passati da un luogo dove avere un contatto con il soprannaturale tipico di alcune civiltà antiche, a un vero e proprio sistema fondante dello sviluppo urbanistico di molte città europee del XIX e del XX secolo. Tuttavia è possibile notare come in Italia, nonostante una tradizione millenaria dell’uso del verde, si sia persa la capacità di utilizzare gli spazi verdi urbani e periurbani come elemento integrante dello sviluppo urbanistico. Spesso sia il verde urbano che quello periurbano, sono stati utilizzati come spazi in attesa di edificazione senza l’attribuzione di valori propri. Anche la maggiore sensibilità sviluppatasi a partire dal XX secolo e che ha innescato un cambiamento culturale che si ripercuote in una maggiore sensibilità verso gli spazi verdi e l’ambiente in generale, non è riuscita ad affrancarsi in modo organico da forme di tutela di tipo vincolistico che, sovente, non riescono a coniugare le esigenze di protezione con quelle di valorizzazione e produzione, specialmente quando si tratta di aree agricole periurbane.
È importante sottolineare come la gestione e la progettazione del verde urbano e periurbano non deve essere priva dei processi partecipativi che possano coinvolgere la cittadinanza attiva nelle scelte effettuate, perché realizzare parchi urbani e periurbani non è da intendersi soltanto come un semplice processo di abbellimento o di valorizzazione, ma corrisponde all’assunzione delle responsabilità da parte del progettista consapevole di andare ad operare in un contesto storico ed evolutivo che caratterizza la città e i suoi dintorni. Progettare in zone urbane o periurbane non può prescindere dall’indispensabile coinvolgimento della popolazione sia in fase di stesura delle ipotesi progettuali sia nella futura gestione e manutenzione delle aree specialmente in un momento in cui le risorse pubbliche diventano limitate.
Bibliografia essenziale
– DUVERNOY I., JARRIGE F., MOUSTIER P., SERRANO J., 2005, « Une agriculture multifonctionnelle dans le projet urbain : quelle reconnaissance, quelle gouvernance ? », in Fleury A. (a cura di) (2005), Multifonctionnalité de l’agriculture périurbaine. Vers una agriculture du project urbain, Les Cahiers de la multifonctionnalité, n. 8, Mai 2005, INRA, CEMAGREF, CIRAD, pp. 87-104.
– FANFANI D., 2006, Il governo del territorio e del paesaggio rurale nello spazio “terzo” periurbano. il parco agricolo come strumento dipolitiche e di progetto. Ri-Vista Ricerche per la progettazione del paesaggio ISSN 1724-6768 pagg. 54-69
– GIACCHÈ, G., 2012, “Verso una maggiore integrazione dell’agricoltura nella pianificazione territoriale. Analisi e proposte per i Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara. “Associazione “”Alessandro Bartola”Il Mulino, 395-406.
– MAZZOCCHI C., 2011, Il ruolo dell’agricoltura periurbana nelle dinamiche di consumo di suolo: l’indicatore di rischio di consumo di suolo agricolo. Tesi di dottorato. Università degli Studi di Padova. Scuola di dottorato di ricerca in: Territorio, Ambiente, Risorse e Salute. Indirizzo: Economia agraria. Ciclo XXIII.
– SANESI G., 2001, Le aree verdi urbane e perturbane: situazione attuale e prospettive nel medio termine.
– TORQUATI B.M., GIACCHÈ G., 2010, “Rapporto città-campagna e sviluppo rurale”, Agriregionieuropa, anno 6, n. 20.
Marco Giuseppi, diplomato all’Istituto tecnico agrario, ha conseguito la laurea triennale in Scienze forestali ed ambientali e la laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali presso l’Università degli studi di Firenze. Curriculum vitae >>>
|