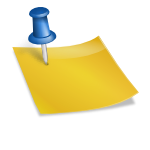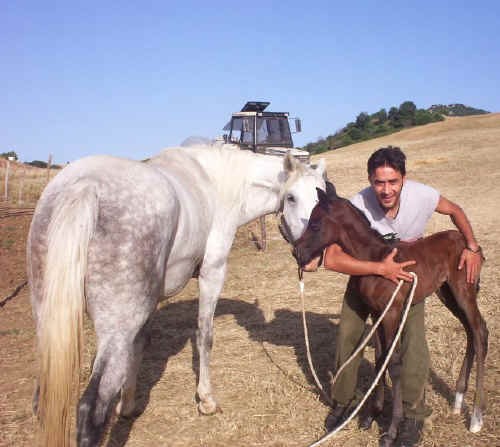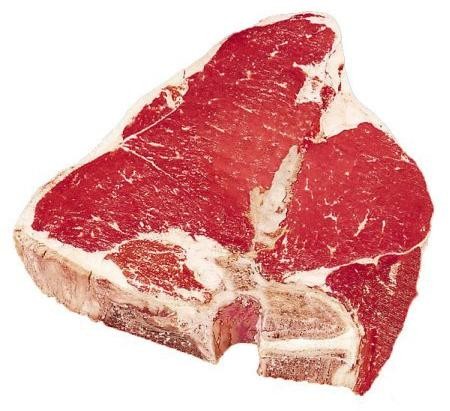di Alfonso Pascale
Gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) sono stati dichiarati senza rischi da numerosi organismi di controllo nazionali e internazionali. E tuttavia per molti cittadini, la sigla OGM è sinonimo di cibo da evitare, o perché rischioso per la salute o perché imposto al mercato dagli interessi delle multinazionali. Questo paradosso crea un circolo vizioso: quanto più gli OGM sono percepiti non sicuri, tanto più si procede a nuove analisi, sempre più costose, anche se i cibi derivati da coltivazioni transgeniche attualmente sono gli alimenti in assoluto più regolamentati.
Siamo, dunque, in presenza di una dicotomia tra rischio reale e rischio percepito. E la percezione della sicurezza alimentare dipende da come viene comunicato il rischio e da quanto il cibo è sentito come “familiare” o “estraneo”, “naturale” o “tecnologico”.
Il problema sanitario principale che riguarda il cibo è di carattere batterico o virale. Ma l’idea di intossicazione è familiare, cioè non richiede di essere compresa dal punto di vista tecnico; e non è avvertita come imposta in modo volontario da qualcuno. E’ per questo che le persone non si sentono minacciate. Al contrario, esse non accettano gli OGM perché queste piante sono percepite come “estranee”, “tecnologiche” e per giunta imposte da forze potenti, anche se non ci sono prove che possano essere pericolose.
La questione degli OGM attiene in massima parte alla sua dimensione culturale e chiama in causa diversi elementi. Innanzitutto, il comportamento diversificato degli intellettuali e dei comunicatori che contribuiscono a creare il senso comune. Sono pochissimi quelli che esprimono opinioni su problemi complessi valorizzando conoscenze acquisite con metodo scientifico e molteplici strumenti di misura. L’altro elemento è la funzione dei mass-media, che non garantiscono una condizione di imparzialità nell’informazione e un confronto civile tra le diverse posizioni. Infine, la dicotomia tra rischi reali e rischi percepiti pone un problema di convivenza tra differenti visioni culturali ed etiche anche nell’ambito delle questioni scientifiche e di un nuovo rapporto tra scienza e democrazia. Si tratta di aspetti importanti che vanno affrontati seriamente se si vuole guardare con fiducia al futuro, puntando sull’innovazione.
In Italia, il problema si presenta con una sua propria specificità perché il nostro Paese è caratterizzato da una diffusa avversione alla scienza, dettata spesso da timori egoistici e paure millenaristiche. Del resto, da noi il livello delle competenze e delle capacità cognitive scientifiche e tecniche non è stato mai considerato un criterio importante almeno pari a quelli normalmente ritenuti necessari per la nascita e la sopravvivenza di una democrazia liberale e non dispotica.
Molti affermano che l’autonomia e l’autodeterminazione sono i valori davvero in grado di garantire un efficiente funzionamento delle regole democratiche, ma poi dimenticano che solo la diffusione della scienza è in grado di sviluppare negli individui e nelle comunità il senso di autonomia. E nell’attuale società del rischio, solo la scienza permette di acquisire dati e valutazioni per poter plasmare i comportamenti e i valori civili che consentono di controllare democraticamente la sostenibilità delle premesse su cui si reggono i processi moltiplicativi della modernità.
Neonazionalismo e autarchia italica
Per comprendere la questione degli OGM nella sua dimensione culturale è necessario conoscere cosa è avvenuto negli ultimi trenta anni all’interno del mondo della ricerca genetica agraria.
A metà degli anni Ottanta, un gruppo di genetisti agrari lancia l’idea di abbassare la dose di chimica in agricoltura intervenendo sul DNA delle piante, corazzandole contro gli insetti e contro le avversità atmosferiche. I diserbanti di prima generazione avevano, infatti, inquinato le falde acquifere. E gli agrofarmaci distribuiti con mano pesante, avevano creato squilibri nella microfauna. Per fronteggiare i disastri ecologici che si erano prodotti nel tempo, i genetisti agrari, che avevano fino a quel momento spostato geni facendo un’infinità di prove a caso prima di individuare quello responsabile del carattere ritenuto utile e trasferirlo, trovano un nuovo modo di intervenire sui geni per guadagnare tempo nelle sperimentazioni e affrontare i nuovi nodi che la questione ambientale pone. Decidono così di sviluppare il DNA ricombinante. Grazie alla scoperta degli enzimi di restrizione, capaci di tagliare un pezzo di DNA, possono trasportare con precisione quel particolare gene che esprime un carattere agronomico utile.
Tra l’approccio precedente, fatto di ibridazioni e d’incroci oppure di radiazioni, e il nuovo approccio, fondato sul DNA ricombinante, la differenza è che la quantità di geni spostati è piccola, uno o più geni. Non si spostano più centinaia o migliaia di geni che potenzialmente possono cambiare di posizione. Inoltre, con la nuova tecnica si può controllare con più precisione il cambiamento in atto. Così alcuni ricercatori che operano in diverse strutture pubbliche trovano anche il modo per salvare alcune specie vegetali che corrono il pericolo di estinguersi. Tra queste il melo della Valle d’Aosta, attaccato da un coleottero molto molesto che ha l’abitudine di cibarsi delle sue radici; il pomodoro San Marzano sensibile alle virosi e il riso Carnaroli attaccato dal “mal del collo”.
Tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo secolo queste sperimentazioni, volte a creare OGM per risolvere alcuni problemi riguardanti le nostre specialità tipiche, vengono bloccate da due ministri: Alfonso Pecoraro Scanio e Gianni Alemanno. Essi infliggono un colpo mortale a un’attività di ricerca pubblica che in Italia è all’avanguardia. I nostri scienziati vogliono, infatti, affrontare una serie di problemi creati dalla Rivoluzione verde e vedono nelle nuove conoscenze e nei nuovi strumenti tecnologici una seria possibilità per farlo. Ma istituzioni pubbliche e strutture sociali, di comune accordo, interrompono queste attività che non vengono più finanziate.
Si forma così una spuria alleanza, rinchiusa nella tutela di una malintesa italianità, frutto del raggrumarsi di subculture che rispondono impaurite e rabbiose alla globalizzazione e ai nuovi equilibri mondiali, in cui emergono Paesi con un tasso di crescita prima inimmaginabile. Un’alleanza che preme sul governo per bloccare l’utilizzazione in Italia delle sementi OGM regolarmente approvate da Bruxelles; che ottiene dal Parlamento leggi sull’etichettatura degli alimenti o sulla percentuale di alchil esteri nell’olio d’oliva da usare come armi puntate verso gli organismi europei – a cui è invece demandato il compito di legiferare su tali materie – per tentare di condizionarli nelle scelte.
Emerge, dunque, una sorta di neonazionalismo autarchico che esclude ogni collaborazione con le agricolture di altri Paesi, considerate come nemiche da combattere, e preme ostinatamente sulle istituzioni perché si riprendano quella sovranità nazionale che un tempo si era disposti a sacrificare per l’obiettivo di un ideale collettivo europeo.
Il tutto nasce dall’esasperazione della tipicità come strategia volta ad affrontare la globalizzazione eludendo la competizione da costi. La scelta della tipicità è così concepita non solo come percorso per differenziare e dare un valore aggiunto ad un prodotto. Un alimento tipico non ha, infatti, concorrenti e appartiene, però, a tutti i produttori. Ha un valore immateriale racchiuso nella provenienza geografica e nel disciplinare di produzione ricavato dalla memoria storica del territorio. Ma, a torto, tale percorso viene ritenuto anche come l’unico capace di affrontare i mercati globali. E così viene teorizzato in modo strumentale un insanabile contrasto tra produzioni tipiche e piante OGM, negando così in radice l’assunto scientifico con cui i nostri ricercatori avevano avviato le nuove sperimentazioni. E si fa passare questa tesi antiscientifica mediante una serie di programmi promozionali e di comunicazione in materia di alimenti, con un dispendio enorme e insensato di risorse pubbliche.
Sicché, attualmente il mercato degli OGM è quasi monopolizzato da una sola multinazionale, la Monsanto. E il motivo sta nel fatto che inizialmente i brevetti provenivano dalle università pubbliche; ma a seguito delle campagne promozionali all’insegna della parola d’ordine priva di giustificazioni scientifiche “gli OGM sono dannosi alla salute e all’ambiente”, la Monsanto ha acquistato gran parte dei brevetti dalle università. E la scelta di questa impresa privata di effettuare ricerche solo su piante di elevata diffusione, come il mais, e non su produzioni tipiche è ovviamente dettata da una convenienza economica e non da un intento malevolo. È, infatti, la ricerca pubblica che dovrebbe puntare a risolvere i problemi delle produzioni di nicchia. Dunque, il teorema costruito sulle coppie tipico/sano e OGM/dannoso, tipico/naturale e OGM/artificiale, tipico/italiano e OGM/straniero, tipico/imprese locali e OGM/multinazionali, è appunto un teorema inventato in modo miope da chi è seduto sul ramo che egli stesso è intento a segare.
La cultura della tipicità, da strumento di conoscenza delle distinzioni e della storia alimentare, viene esasperata fino al punto di trasformarla in arma di difesa economica nella competizione globale.
Sicché, il considerevole patrimonio di ricerche condotte dall’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) sui prodotti tradizionali diventa non già sussidio didattico nelle scuole e nelle aggregazioni sociali, ma materiale da distillare in marchi e marchietti da apporre sulle etichette delle confezioni. E ogni ulteriore novità che si discosta o sembra allontanarsi dal tipico viene sacrificata in nome del made in Italy. Il tutto mediante una comunicazione semplificata, aggressiva, provocatoria, per lo più realizzata a spese del pubblico erario.
E così, proprio ora che gli scambi non solo economici diventano nel mondo più ampi e ramificati, si rinuncia in sostanza alla principale prerogativa che il nostro Paese ha avuto in passato: quella di assimilare altre culture e ricrearle in modo così originale da farle apparire come se fossero sempre appartenute al nostro DNA.
In sostanza, si coltiva artatamente l’illusione che la nostra cultura agroalimentare possa difendersi da quelle dei Paesi emergenti con le leggi e i tribunali e non invece con l’innovazione, la ricerca scientifica, la creatività, il gusto di essere imitati per ricavarne la spinta a superare noi stessi.
Oltre la specie con speranze ragionevoli
Siamo appena entrati in una nuova rivoluzione tecnologica. E ciò che traspare all’orizzonte è il superamento della separazione tra storia della vita e storia dell’intelligenza. Le basi naturali della nostra esistenza smetteranno presto di essere un presupposto immodificabile dell’agire umano. La nostra natura, nella sua interezza, diventerà un risultato storicamente determinato della nostra cultura. L’intelligenza umana e quella non biologica presto si alleeranno. E così entreremo nella cosiddetta “Singolarità”.
E quando sfonderemo tale soglia, saremo oltre la specie, in una dimensione non più “naturale” ma interamente “culturale” dell’umano. A detta dei futurologi, tale condizione aprirebbe prospettive inedite oggi difficili da intravedere. In una cultura come quella italiana, nutrita di antimodernismo e di sensazionalismo giornalistico, la sola evocazione di siffatte novità suscita una reazione di rigetto. Ma senza peccare di ottimismo tecnologico e senza ricorrere ai grandi racconti fantascientifici, si possono senz’altro nutrire quelle che il filosofo e storico della scienza, Paolo Rossi, chiamava speranze ragionevoli entro un futuro incerto e difficile.
Tra l’Apocalisse e le Grandi Speranze c’è la giusta misura con cui guardare al domani a condizione, tuttavia, che in Italia si abbandoni la demonizzazione della tecnica applicata alla natura umana e alla natura in generale. La violenza della polemica ha sfiorato addirittura il paradosso. All’oncologo Umberto Veronesi che dichiarava “Se potessi scegliere, preferirei nutrirmi di mais transgenico”, lo storico Piero Bevilacqua replicava in modo perentorio: “Affermiamo senza difficoltà che, di fronte a un mondo a così alto rischio, la fede incondizionata che anche intellettuali liberi nutrono nei confronti della tecnoscienza rappresenta un aspetto costitutivo della superstizione contemporanea”.
Lo studioso accusa di atteggiamento fideistico e superstizioso quei settori che si battono per la libertà della ricerca scientifica da posizioni laiche. Perché? I termini fede e superstizione tirati in ballo dallo storico fanno emergere una novità che non tutti colgono: oggi non solo i diversi punti di vista sono percepiti come credenze o fedi, indipendentemente se queste siano religiose o meno, ma anche i dati scientifici sono assimilati alle credenze. Da una parte della cultura italiana il metodo scientifico non è più riconosciuto ed è considerato superfluo.
Gli intellettuali e gli scienziati che a esso continuano a ricorrere nella loro attività dovrebbero, pertanto, attrezzarsi per farlo valere nella società mediante un’azione pedagogica e un impegno civile di ripensamento della democrazia.
Occorre un’innovazione sociale
Che si debba porre mano alla democrazia, ai suoi fondamenti etici e ai modi di produrre decisioni condivise, appare ormai scontato in una società che diventa sempre più multiculturale. Non si tratta solo di una molteplicità d’interessi particolari o di punti di vista limitati, che si possono trascendere in sintesi superiori, ma di un pluralismo che è parte integrante dell’opera della ragione pratica libera, entro la cornice di libere istituzioni.
Dinanzi a questa novità, le istituzioni politiche dovrebbero assumere un atteggiamento laico e tollerante. Si tratta di accettare il pluralismo non come modus vivendi o come necessità, ma per adesione profonda a un regime di libertà e ai suoi principi. Pertanto, l’idea stessa di laicità, che non riguarda più solo il rapporto tra Stato e confessioni religiose, andrebbe rifondata.
La nuova laicità presuppone uno Stato neutrale tra le diverse concezioni e indipendente da qualunque dottrina. Ma quando i dati scientifici devono necessariamente supportare le decisioni, in che modo si potranno difendere da eventuali manipolazioni? Non è semplice rispondere a questa domanda. Si può tentare qui di prospettare un’ipotesi. La nuova laicità dovrebbe presupporre non già il mero riconoscimento di una comunità scientifica che si autogestisce nel produrre una conoscenza affidabile mediante percorsi collettivi di controllo e approvazione, bensì l’immersione degli scienziati nella società civile per interagire con l’insieme dei cittadini e contribuire dal basso alla formazione dei punti di vista.
Si tratta, in sostanza, di produrre un’innovazione sociale che cambia la qualità e l’estensione delle relazioni per fare in modo che la conoscenza si diffonda e diventi effettivo diritto di cittadinanza. A quel punto la scienza e il metodo scientifico possono diventare concretamente un pilastro costitutivo della democrazia.
Ci vorrebbe una politica capace di delineare progetti fattibili volti ad anticipare la forma civile che le grandi strutture della tecnoeconomia già cominciano a ridisegnare in solitudine e, dunque, nel pericolo. Ma prima ancora della politica, avremmo bisogno di una nuova etica che dovrebbe maturare nella società civile. Di quale etica? A questa domanda risponderei con Aldo Schiavone così: “Di un’etica che sappia trovare il divino nell’accrescersi delle facoltà dell’umano e non nella sacralità della natura. Di un’etica della trasformazione e non della conservazione; che accolga le responsabilità e non le respinga; che non rifiuti l’aumento illimitato di potenza, ma ne determini gli obiettivi; che non consideri definitivo nessun assetto biologico o sociale, ma accetti di considerarli tutti come figure del mutamento e della transizione; che cerchi le sue leggi non nella natura, ma nell’intelligenza e nell’amore”.
È questo il livello cui il dibattito sulle biotecnologie dovrebbe tendere per favorire percorsi efficaci, benché complessi, al fine di giungere a decisioni condivise. Ma in Italia le istituzioni (e anche i mass media) non garantiscono condizioni d’imparzialità, indipendenza e laicità per un confronto civile tra le diverse posizioni. E nelle reti sociali non nascono ancora azioni di monitoraggio e correzione (con analisi di dati dettagliati e rigorosi ricorsi alle fonti scientifiche), interdisciplinari e gratuite, a sostegno delle persone che intendono avvalersene nella formazione delle opinioni.
Alfonso Pascale (1955) si occupa di agricolture civili, campagne urbane e di tutto quello che ruota intorno al cibo. Collabora con istituti per la ricerca socio-economica e la formazione. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui “Partire dal territorio” (RCE 2002), “Il ’68 delle campagne” (RCE 2004) e, ultimamente, “Radici & Gemme. La società civile delle campagne dall’Unità ad oggi” (Cavinato Editore International, 2013), che ricostruisce fatti e idee riguardanti i ceti rurali, compresi i professionisti e i tecnici, e il loro rapporto con lo Stato. Nel 1977 è stato tra i fondatori della Confederazione Italiana Agricoltori, in cui ha svolto il ruolo di vice presidente nazionale (1992-2002). Nel 2005 ha fondato la Rete Fattorie Sociali di cui è stato presidente fino al 2011. Ha un sito personale www.alfonsopascale.it
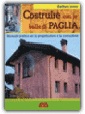 |
Costruire con le balle di paglia |