di Matteo Fabbri
Una delle malattie più dannose per le piante delle alberature cittadine dell’area mediterranea è costituita dal “Cancro colorato” del platano che ha come agente causale il fungo ascomicete Ceratocystis platani Walter, forma speciale morfologicamente indistinguibile da altre forme con ospiti diversi, come le patate dolci (Ipomoea batatas), il caffè (Coffea arabica), il cacao (Theobroma cacao), l’albero della gomma (Hevea brasiliensis), pioppo tremulo (Populus tremula). riguarda specie appartenenti al genere Platanus e in particolare Platanus orientalis, Platanus occidentalis, Platanus acerifolia.
Il fungo ascomicete Ceratocystis platani, agente patogeno del cancro colorato del platano è una specie alloctona di importanza rilevante, ed è stata inserita nella Lista degli organismi nocivi trattati con regime di quarantena (A2) dalla EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).
Modalità di infezione
L’infezione delle piante avviene attraverso ferite causate da insetti, uccelli, piccoli roditori o mediante anastomosi radicali. La diffusione della patologia fra piante e da una zona all’altra è in massima parte dovuta all’impiego, durante le potature, di attrezzi da taglio infetti con i propaguli del patogeno.
Le lesioni provocate dall’uomo con potature, lavori lungo le strade strade alberate possono essere considerate come la causa principale di diffusione. Il fungo invade rapidamente gli elementi xilematici provocando la produzione di tille che occludono i vasi legnosi. L’imbrunimento del legno è dovuto soprattutto alla reazione della pianta e alla diffusione del micelio e di conidi. All’interno dei vasi dell’alburno esso genera la forma endoconidica che si diffonde per via vascolare dando luogo ad una vera e propria tracheomicosi.
Sulle superfici infette e in corrispondenza di ferite, con temperature comprese trai 5°C e i 35°C, il fungo germina producendo conidi che diffondono l´infezione. Il micelio fungino si accresce ad una temperatura ottimale di 25°C, ma può essere attivo anche a temperature di 10°C.
Nella segatura infetta rimasta nel terreno il patogeno può essere ancora vitale dopo 5 anni. L’esposizione per alcune ore a 45°C comporta la disattivazione del fungo.
Sintomatologia

Chioma con evidenti disseccamenti e microfillia (foto Matteo Fabbri)
Il cancro colorato del platano si può presentare con due differenti sintomatologie:
– Acuta: sulla chioma in primavera-estate si manifestano improvvisi disseccamenti di alcune branche o dell’intera chioma; le foglie seccano e possono rimanere attaccate ai rami anche per lungo tempo.
– Cronica: la pianta si presenta deperita, con foglie piccole e clorotiche. La ripresa vegetativa avviene in ritardo rispetto ai soggetti sani e dopo circa 2-3 anni la pianta entra precocemente in riposo vegetativo, non germogliando più nella primavera successiva.
Su tronco o branche la sintomatologia consiste nella formazione di cancri più o meno estesi con fessurazioni longitudinali della corteccia e, a volte, riscoppi di vegetazione al di sotto o a lato degli stessi. I margini della ferita non presentano callo di cicatrizzazione. Sui fusti è possibile, soprattutto nei platani a corteccia liscia (P. occidentalis), osservare anomale colorazioni rosso-bluastre che percorrono il tronco, simili a fiammate.
In corrispondenza delle necrosi, asportando la corteccia, sono osservabili alterazioni cromatiche scure dette “a macchia di leopardo”. Sezionando il tronco è possibile notare la colorazione anomala bluastro-violacea con sfumature brunastre o rossastre estendersi lungo i raggi midollari sino al midollo centrale.

Tipica sintomatologia a “macchia di leopardo” (foto Matteo Fabbri)
Epidemiologia
La prima segnalazione della malattia risale al 1926 nel New Jersey e da qui si è progressivamente estesa a varie zone della fascia orientale degli USA e successivamente in Europa.
Durante la Seconda Guerra Mondiale il legno infetto è stato utilizzato per la costruzione di imballaggi per le provviste e questo probabilmente è il mezzo con cui il patogeno è arrivato in Europa. Questa supposizione è nata dal fatto che i primi focolai in Europa si sono sviluppati nei pressi delle maggiori città portuali: Napoli, Livorno, Siracusa, Marsiglia, Barcellona.
In Italia il cancro colorato si è manifestato nel 1954 in Campania, particolarmente a Caserta, dove ha completamente distrutto le piante secolari che costituivano l’alberatura monumentale del viale di accesso alla famosa reggia della città. Bisogna tuttavia attendere gli anni ´70 per registrare una forte espansione dell’areale di diffusione dell´infezione in altre regioni e precisamente in Toscana a Forte dei Marmi.
Negli ultimi anni la malattia si è diffusa in Francia anche in zone a forte richiamo turistico, come il Canal Du Midi, sito incluso nel Patrimonio dell’Umanità (UNESCO).
Prevenzione e lotta al cancro colorato
La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno C. platani, risulta piuttosto difficile e consiste in operazioni preventive e di eradicazione regolate da norme di “Lotta obbligatoria” valide su tutto il territorio della Repubblica italiana.
Il controllo di questa fitopatia si basa quindi sul rispetto di una serie di norme di profilassi come indicato nelle circolari applicative del D.M. 29 Febbraio 2012, n. 60166 (che abroga i precedenti).
All’interno delle circolari applicative del decreto sono indicate le modalità di abbattimento, trasporto e smaltimento del legname infetto.
L’esempio di Firenze
Le osservazioni e i rilievi effettuati a Firenze per verificare la situazione della diffusione del cancro colorato del platano da C. platani confermano la pericolosità di questo agente fungino e non differiscono con analoghi dati raccolti in altre città italiane ed europee.
I dati del monitoraggio confrontati i rilievi raccolti nel 1995 hanno dimostrato che a 18 anni di distanza il patogeno prosegue la sua avanzata. Le osservazioni eseguite nell’autunno del 2012 hanno messo in evidenza la presenza di un totale di 25 piante infette su un totale di 630 esaminate, presenti nelle aree monitorate in complessivi 11 focolai attivi su 16 siti di rilievo.
Dai rilievi effettuati è emerso che le piante colpite costituiscono il 4% delle totali, i reimpianti il 30% e le ceppaie e vuoti il 10%, le perdite totali sono del 44% circa (assumendo che i reimpianti e le ceppaie e vuoti si siano originati per motivi inerenti alla patologia).
Si è anche rilevato che il alcuni casi laddove il patogeno era stato individuato nel 1995 o in anni successivi non è stata più individuata la patologia (Manifattura tabacchi, Piazza Puccini, Viale Matteotti e Via Pistoiese). In alcuni casi è stata effettuata una severa opera di bonifica, con numerosi abbattimenti (p.es. Piazza Puccini), che ha modificato in modo evidente l’aspetto della piazza; in altre situazioni si è provveduto invece alla totale sostituzione dei platani con altre specie (Viale Giovine Italia).
Al fine di preservare il patrimonio verde della città, per quanto riguarda i platani, è necessario dunque effettuare decisi interventi di estirpazione nelle zone in cui il patogeno è già presente, cercando il più possibile di “isolarle” da quelle vicine ma non ancora colpite.
Inoltre l’utilizzo della varietà resistente (“Vallis Clausa”) e il potenziamento dei mezzi di ricerca (per la lotta biologica o l’individuazione dei vettori), possono fornire strumenti adeguati e migliori al fine di contrastare questa difficile patologia che non lascia scampo ai nostri platani.
Questo articolo è l’estratto della tesi di laurea di Matteo Fabbri in Scienze forestali ed ambientali, Università degli Studi di Firenze, dal titolo: “Studio sull’incidenza del cancro colorato del platano a Firenze”.
Matteo Fabbri, diplomato all’Istituto tecnico agrario, ha conseguito la laurea triennale in Scienze forestali ed ambientali presso l’Università degli Studi di Firenze. E’ iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali.
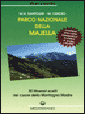 |
Parco Nazionale della Majella La Majella è un gigante da scoprire passo dopo passo, guidati dall’esperienza di chi conosce il Parco… |








