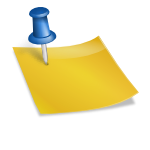Produrre con minori risorse, ridurre l’inquinamento, salvaguardare il potenziale agricolo europeo. Ecco come incentivare la lotta al cambiamento climatico, alla salvaguardia ambientale, e al risparmio idrico.
di Andrea Ambrosini
L’agricoltura ha un ruolo di primo piano per le nuove priorità ambientali: dal contenimento dei consumi allo sviluppo di nuovi fonte energetiche e all’utilizzo dei propri scarti per la creazione di energia nuova; dal miglioramento dell’efficienza dell’irrigazione alle norme per l’impiego di reflui zootecnici e fitofarmaci. E poi ancora dal preservare e incrementare la biodiversità alla lotta all’effetto serra, con lo sviluppo delle foreste e l’abbattimento delle emissioni di origine zootecnica; dalla rinuncia a coltivare le zone di confine dei campi alla creazione di stagni o di altri elementi paesaggistici, andando così oltre le buone pratiche agricole tradizionali.
Tutela delle acque
La qualità e tutela delle acque è una delle priorità ambientali legate all’agricoltura. Al momento attuale il rapporto tra acqua e agricoltura presenta due punti critici: il forte impiego delle acque superficiali o di prima falda per l’irrigazione e il pericolo di eccessiva concentrazione di nitrati o altre sostanze nocive nelle acque medesime.
Cambiamenti climatici
L’effetto dei cambiamenti del clima si ripercuote sull’agricoltura essenzialmente in tre modi: l’aumento delle temperature, la riduzione e concentrazione delle piogge (la cosiddetta “tropicalizzazione”) e il manifestarsi sempre più frequente di eventi atmosferici violenti come grandinate, trombe d’aria, frane e alluvioni. Tutti eventi dannosi per le colture e talvolta anche per le infrastrutture agricole.
Energia dal biogas (prodotto da effluenti zootecnici, biomasse dedicate e di scarto)
La storia del biogas da effluenti zootecnici è stata caratterizzata in Italia da due distinte fasi. La prima, non positiva, risale agli anni ’80, mentre la seconda ha avuto inizio nel decennio successivo, quando tecnologie più semplici e studiate espressamente per il mondo agricolo hanno iniziato ad essere adottate e a garantire agli allevatori un effettivo ritorno economico dell’investimento. Le difficoltà del primo periodo sono per lo più da imputare al fatto che le costruzioni di impianti per biogas, era giustificata dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei liquami, più che dalla volontà di realizzare un risparmio energetico. La situazione è andata modificandosi a partire dalla fine degli anni ’80, quando ha iniziato a diffondersi una nuova generazione di impianti di biogas semplificati e a basso costo, che oltre a recuperare energia permettono di controllare gli odori e di stabilizzare i liquami. Ora l’incentivazione delle energie rinnovabili, in accordo con una direttiva europea, si avvale dei cosiddetti “certificati verdi” (CV) (d.lgs. 387/2003). In pratica, a partire dal 2002 è stato definito l’obbligo, da parte di tutti i produttori ed importatori di energia elettrica da fonte convenzionale, di immettere in rete, ogni anno, una quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili (tra cui il biogas) pari almeno, nel 2006, al 3,05% della quantità totale immessa. Per poter rispettare tale quota, i produttori di energia da fonte convenzionale devono acquistare i cosiddetti “certificati verdi” dai produttori di energia rinnovabile. Attualmente la durata dei CV è di dodici anni (come indicato nel recente testo unico recante norme in materia ambientale, d.lgs. n.152/2006), elevabile per l’energia rinnovabile ottenuta da biomasse, quale è il biogas, per altri quattro anni, anche se con il riconoscimento solo del 60% dell’energia elettrica prodotta (art. 5 del decreto del Ministero Attività Produttive e del Ministero dell’Ambiente del 24 ottobre 2005, G.U. n. 265 del 14/11/2005) e se non si sono ottenuti contributi in conto capitale nella realizzazione dell’impianto. Sulla necessità di ridurre l’emissione di gas serra, così come stabilito dal Protocollo di Kyoto, si basa la riforma della politica ambientale dell’Unione Europea, concretizzata con l’emanazione del Libro bianco sulle energie rinnovabili, della delibera CIPE n. 137/98 sulle politiche nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra. L’applicazione di tecniche di digestione anaerobica (siano semplici coperture degli stoccaggi o reattori anaerobici veri e propri) oltre a ridurre le emissioni di metano porta anche ad una diminuzione delle emissioni di ammoniaca e di altri gas serra, come pure di composti organici volatili non metanici e di composti odorigeni causa di cattivi odori. Non da ultimo, la captazione del biogas permette di sostituire i combustibili fossili con combustibili da fonti rinnovabili.
Sostenibilità dei cicli culturali e riduzione degli impatti in agricoltura
L’ecosistema agrario si sviluppa dalle relazioni tra le componenti naturali, i fattori ambientali e biotici, la coltivazione di piante e l’allevamento di animali. Da questo deriva l’eterogeneità dei diversi territori rurali. Tutti gli ecosistemi sono regolati dal tipo di clima e di suolo, dalla radiazione solare, dall’acqua, dal ciclo degli elementi, che influenzano gli equilibri e le variazioni tipiche del sistema. Nell’agro-ecosistema operano anche i fattori antropici e le scelte di gestione agro-ambientale. In Italia il 21% della SAU (superficie agricola utilizzabile) presenta caratteri di alto valore naturalistico, come i prati e pascoli alpini, su cui poter costituire zone di collegamento tra gli spazi naturali (Strategia Nazionale). È importante scegliere tecniche agronomiche capaci di preservare la struttura e la fertilità dei suoli e ridurre gli impatti ambientali derivanti dall’impiego di prodotti chimici di sintesi. Tra queste pratiche: i sistemi di produzione integrati o biologici, le lavorazioni del suolo conservative, gli avvicendamenti colturali e l’uso di fasce tampone.
Green Economy e Governance per uno sviluppo sostenibile
La Commissione Europea ha adottato una Comunicazione che costituirà il fondamento per la posizione dell’UE alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, in programma per giugno 2012 a Rio de Janeiro (“Rio+20”). La Comunicazione definisce il “cosa, come e chi” del passaggio a un’economia verde e propone azioni specifiche che potrebbero essere attuate a livello internazionale, nazionale e locale. I punti principali sono i seguenti:
1. Investire in risorse chiave e capitale naturale (“cosa”): si tratta di risorse idriche, energie rinnovabili, risorse marine, biodiversità e servizi eco sistemici, agricoltura sostenibile, foreste, rifiuti e riciclaggio. Questi settori forniscono sostentamento a milioni di persone e possono contribuire ad alleviare la povertà. Inoltre, in futuro potrebbero diventare settori chiave della crescita economica e dei mercati mondiali.
2. Combinare strumenti normativi e di mercato (“come”): si tratta di introdurre ecotasse, eliminare sovvenzioni controproducenti sotto il profilo ambientale, mobilitare le risorse finanziarie pubbliche e private e investire in competenze e professionalità legate all’ambiente. Occorre mettere a punto indicatori che permettano di misurare il progresso in senso più ampio (ossia tenendo conto degli aspetti ambientali e sociali) parallelamente al PIL.
3. Migliorare la governance e incoraggiare la partecipazione del settore privato (“chi”): si tratta di consolidare e razionalizzare le strutture attuali di governance internazionale (ad esempio potenziando il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente – UNEP). È essenziale anche accrescere sensibilmente la partecipazione e l’impegno delle imprese e della società civile.
Crediti di carbonio, il ruolo delle imprese agricole nel comparto forestale
Il tentativo di avviare una concreta possibilità di “ricapitalizzare” le imprese agricole, sempre più in difficoltà, attraverso il pagamento dei “Crediti di Carbonio” generati dalle superfici agrarie grazie al processo di “fotosintesi clorofilliana” che determina assorbimento di CO2/produzione di 02, non trova particolare attenzione e pronta risposta da parte delle Istituzioni preposte. Oggi la valorizzazione dei Crediti di Carbonio è una scelta prioritaria, perché grazie alla ormai riconosciuta attività di gestione delle superfici agro-forestali, che generano “Crediti di Carbonio” remunerabile, le imprese agricole operanti in Italia, hanno diritto ad un conseguente e sostanziale ristoro economico riconosciuto per legge, attraverso il posizionamento dei Crediti di Carbonio generati alla Borsa delle Emissioni del CO2. Tutte le imprese – prevede la legge – dovranno essere iscritte al Registro Nazionale di Crediti di Carbonio, crediti che necessitano di essere preventivamente valutati e certificati. Secondo quanto previsto dall’art.7.4 della Delibera CIPE n.123/2002, in recepimento della legge,120/2002 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, realizza il “Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Agro-Forestali”, definito nella natura e nelle funzioni dal “piano dettagliato” per la realizzazione del potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio derivante dalle attività di uso del suolo prevista dalle attività contemplate dal “Protocollo di Kyoto”, dagli art.3.3 (afforestazione – riforestazione –deforestazione ARD) e dall’art. 3.4 (gestione forestale dei suoli agricoli dei pascoli e rivegetazione – superfici erbacee). Un contributo importante nelle strategie per combattere i cambiamenti climatici può quindi venire dal settore agroforestale grazie alla sua capacità di assorbire carbonio (carbon sink). L’agricoltura, infatti, gioca un ruolo significativo in termini di fissazione temporanea di carbonio nei suoli, nelle produzioni vegetali e arboree e nelle biomasse forestali, sia nelle produzioni a base di fibre legnose sia nei popolamenti forestali. Per questo motivo, la promozione di attività che aumentino o conservino tale capacità di assorbimento rappresenta un supporto alle strategie di contenimento e riduzione delle emissioni nei settori energetici e produttivi. In tale ambito, il protocollo di Kyoto ha previsto la possibilità per i paesi industrializzati di utilizzare le foreste e i terreni agricoli per raggiungere gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra (attraverso le cosiddette attività LULUCF – Land-Use, Land-Use Change and Forestry). A fronte di ciò, in Italia, non si è, però, provveduto ad individuare un sistema in grado di valutare correttamente e valorizzare il ruolo del settore agroforestale nell’ambito della creazione dei serbatoi di carbonio, riconoscendo agli imprenditori agricoli, a fronte di impegni di carattere ambientale, un corretto ritorno sulla quota assorbita di loro competenza. Infatti, in Italia, tutto il carbonio assorbito dal settore agroforestale è calcolato come proprietà esclusiva dello Stato. Cosicché, le imprese agroforestali continuano ad attendere la messa a punto di strumenti effettivamente in grado di attribuire un riconoscimento economico alla loro funzione di carbon sink. Una possibilità è legata alla revisione delle funzioni dell’attuale Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali, istituito dal Ministero dell’Ambiente attraverso il D.M. del 1 aprile 2008, che dovrebbe essere finalizzato alla messa a punto di un vero meccanismo di certificazione dei crediti di carbonio. Si tratta, cioè, di attribuire un valore remunerabile all’assorbimento del carbonio, mediante la creazione di crediti di carbonio, certificati da parte di un organo istituzionale (potrebbe farsene carico il Ministero dell’Ambiente). I beneficiari di tale sistema, attraverso una adesione al registro su base volontaria, dovrebbero essere i proprietari della superficie forestale – agricola che concorre a realizzare l’assorbimento nazionale, ovvero i proprietari forestali, agricoli, ma anche enti pubblici che gestiscono le attività agro-forestali eleggibili. Le attività a cui riconoscere la funzione di assorbimento di carbonio potrebbero essere, ad esempio: la non lavorazione dei terreni, la lavorazione minima, la messa a riposo, la costituzione di prati e colture permanenti, la coltivazione di specie a radice profonda, l’impiego di letame e compost, la gestione dei residui di coltivazione compreso il loro impiego a fini energetici, il miglioramento delle tecniche di fertilizzazione e di irrigazione, la reintroduzione delle rotazioni, la diffusione del metodo biologico e tutti i cosiddetti cambi d’uso del suolo che caratterizzano la trasformazione di superfici agricole in boschi, prati e pascoli. È evidente che, una volta definito il meccanismo di certificazione dei crediti di carbonio, sarebbe opportuno concordare la convertibilità di tali crediti in quote di emissioni scambiabili in un mercato creato ad hoc. In attesa di una revisione della direttiva Emission Trading, si potrebbe, in ogni caso, consentire alle imprese nazionali la possibilità di compensare le proprie emissioni con investimenti nel settore agricolo, per l’ottenimento di crediti di carbonio “compensativi”. Si tratterebbe, in sostanza, di istituire un meccanismo di compensazione a livello nazionale, attraverso il quale anche lo Stato potrebbe utilizzare i crediti generati dal settore agricolo per il raggiungimento dell’obiettivo di Kyoto grazie a :
- creazione di un mercato aperto al più ampio numero di soggetti, sul quale scambiare i crediti di carbonio che rappresentano unità di carbonio assorbite con misure agro-forestali;
- quote di carbonio che corrispondano a unità di emissioni abbattute.
La questione del bilancio del carbonio nel suolo, sebbene, come abbiamo detto, rappresenti una delle opzioni previste dal protocollo di Kyoto per mitigare l’effetto serra, non è stata ancora oggetto di un adeguato approfondimento nelle analisi condotte dalla letteratura scientifica italiana. A livello nazionale manca, ad oggi, uno studio per la stima dell’assorbimento potenziale di carbonio conseguente all’applicazione delle misure agronomiche incoraggiate dalle politiche internazionali per la lotta al cambiamento climatico. Pur essendo noto, a livello generale, che le condizioni favorevoli alla cattura del carbonio da parte del suolo sono legate a diversi fattori (aumento degli input di sostanza organica, diminuzione del suo grado di decomposibilità, ecc.) che possono essere determinati applicando specifiche misure agronomiche, va, tuttavia, rilevato che il grado di incertezza nella stima del carbonio sequestrabile tramite tali pratiche è particolarmente elevato. Ciò è dovuto al fatto che le variabili che influenzano la capacità di assorbimento di carbonio di un suolo sono molteplici, spesso correlate, e specifiche del territorio in cui esso è localizzato (ad es.: clima; uso delle terre precedente; lunghezza del precedente uso delle terre; durata del nuovo uso; profondità del suolo alla quale viene analizzato il carbonio, ecc.). Un altro aspetto condizionante, inoltre, è rappresentato dal fatto che le misure agronomiche che possono essere individuate a questo scopo possono comportare parallelamente degli impatti ambientali negativi.
Giuseppe Andrea Ambrosini, è Agrotecnico iscritto al Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della provincia di Milano, Lodi e Monza Brianza. Dal 1993 al 1995 è stato Segretario della Consulta degli Agrotecnici di Milano e componente del Coordinamento Nazionale Agrotecnici. Nel 2007 è stato eletto Consigliere dello stesso Collegio, con delega del Presidente alla Comunicazione Istituzionale e alla Formazione Professionale. E’ funzionario dell’Ambiente – Tecnico Specialista presso la Regione Lombardia. http://www.agraria.org/rivista/curriculumambrosini.htm
 |
Ebook – Permacultura |